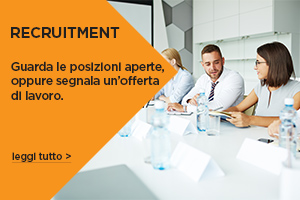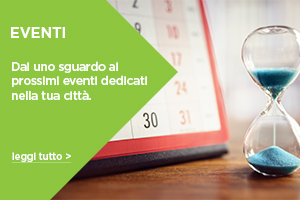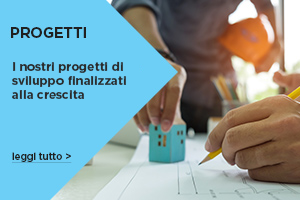La vicenda degli aumenti generalizzati dei prezzi dei biglietti ha sollevato il più complesso problema della gestione dei servizi di trasporto pubblici o semi-pubblici, nell’ambito della Regione Campania.
E’ una questione articolata, che s’intreccia con il problema dell’”accesso” che, a sua volta, impatta sui processi di nuova democratizzazione nelle società avanzate, legati al rapporto tra economia (nuova e vecchia), collettività (nomadi e stanziali) e politica (senza aggettivi), che pone al centro di ogni ragionamento la crescita delle città e la loro fruizione.
Sergio Vetrella – attuale Assessore ai Trasporti della Regione Campania – ha motivato la decisione degli aumenti dei ticket di viaggio, giustificandoli in nome del dissesto della finanza pubblica regionale, cui avrebbe contribuito il debito accumulato dalle aziende aderenti al Consorzio UnicoCampania.
La cifra di 18 milioni d’euro l’anno andrebbe ad aggiungersi, secondo Vetrella, ad altri sforamenti di bilancio che l’attuale amministrazione di centro-destra ha trovato, ad esempio, nelle aziende di proprietà regionale, quali l’Ente Autonomo Volturno che controlla la Circumvesuviana e la Sepsa. Il riferimento, più o meno diretto, è alla gestione di Ennio Cascetta – ex Assessore Regionale ai Trasporti – della precedente Giunta presieduta da Antonio Bassolino.
[intervista integrale all’Assessore Vetrella]
E’ evidente che Vetrella come Cascetta siano “portatori sani” di una diversa visione del mondo, alternativa si potrebbe dire.
Talvolta, però, esse si presentano anche come inconciliabili con le esigenze primarie espresse dai cittadini: vivere, muoversi, lavorare, studiare hic et nunc.
Può accadere quindi che, nel lungo periodo, la creazione di un mercato dei trasporti competitivo e non assistito dalle finanze pubbliche – come sembra trasparire dalla strategia di Vetrella – non s’incontra con le esigenze materiali di mobilità quotidiana e qualità della vita richieste dai cittadini subito. Allo stesso modo, la strategia di Cascetta di sostenere il comparto dei trasporti per creare occupazione, che è sembrata essere una politica utile ai fini del contrasto alla crisi economica (che in Campania sarebbe stata senz’altro più grave che altrove), ha anche contribuito a calmierare i prezzi dei ticket di trasporto, offrendo un’utile semplificazione nell’accesso ai mezzi pubblici (Unico), salvo lasciare però in eredità al centro-destra un debito da ripianare. Insomma, qualunque sia la visione del mondo, non c’è politica virtuosa a priori.
Su questi aspetti emergono almeno tre elementi di riflessione: primo, siamo sicuri che l’aumento del ticket di viaggio non abbia in qualche modo leso il diritto alla mobilità ed all’utilizzo dei trasporti pubblici dei cittadini, in particolare di coloro che hanno minori risorse economiche? E che costoro non ne abbiano ricavato un maggiore disagio nella ricerca di un lavoro, nella frequenza della scuola, nella vita quotidiana in genere? Il secondo elemento riguarda il passato ed il futuro di una decisione politica e la continuità dei servizi, la comprensione degli scenari in veloce mutamento. In altre parole, perché chi si appresta ad occupare una poltrona non si preoccupa mai di parlare e scambiarsi informazioni con chi quella poltrona l’ha occupata per un po’ di anni. Perché la nostra classe politica è incapace di ragionare secondo il “metodo della staffetta”, soprattutto quando la staffetta è necessaria per il “bene pubblico”?
L’ultimo elemento di riflessione attiene, invece, alla mancanza di un piano di comunicazione per informare i cittadini non solo sulla riforma dei trasporti, ma sulle ragioni che l’hanno determinata e sugli effetti sociali attesi, nel breve e nel lungo periodo.
Proviamo a guardare qualche categoria sociale, ad esempio agli studenti. Ad essi è stata prima sbandierata la sopportabilità dell’aumento contenuto delle tasse scolastiche ed universitarie, per poi rendere loro economicamente più gravoso l’”accesso” ai corsi costringendoli a “razionalizzare” la loro mobilità sul territorio. Ma l’effetto più serio, che appare come il primo segnale di quello che accadrà al mercato dei trasporti ri-privatizzato (come nel sogno di Vetrella e del centro-destra in genere), riguarda il taglio delle corse cosiddette “improduttive”. Corse per villaggi fuori mano, o per un’utenza considerata residuale, quali gli anziani, i residenti nelle periferie della regione, gli utenti di servizi prevalentemente destinati a raggiungere i grandi complessi ospedalieri, i cimiteri, i mercatini fuori porta. Con il risultato di realizzare una nuova dis-economia, un paradossale allontanamento dei piccoli centri dai percorsi del turismo. Infine, le aziende di trasporto, a seguito della riduzione del finanziamento pubblico, hanno provveduto subito a tagliare le corse con il risultato di ingolfare le poche rimaste oltre i limiti di sicurezza: anziani, bambini, turisti stritolati nella calca di autobus indecenti e maleodoranti.
L’immagine della città di Napoli e del turismo in Campania di certo non ne gioverà. L’abolizione del metrò del mare avrà, ad esempio, degli effetti negativi sulle finanze di molte famiglie della costiera cilentana.
In sintesi, l’aumento del ticket può essere considerato come un assaggio di federalismo. Un federalismo sperequato che pretende di applicare alla Campania la stessa politica di rincari applicata in Lombardia, dove la qualità dei servizi integrati, la densità urbana, e le condizioni socio-economiche sono ben altre, come evidenziato da ogni statistica seria.
L’aumento del ticket può essere considerato anche come una politica suicida, miope rispetto alle politiche della qualità dell’aria e della viabilità. Difatti, la lievitazione dei costi dei trasporti causerà l’aumento del traffico automobilistico, con effetti devastanti sia per l’inquinamento ambientale sia per la salute pubblica. Sul medio-lungo periodo si tratterrà quindi di far fronte a ben altra spesa ed a ben altri sacrifici economici, per mitigare il rischio ambientale o foraggiare la sanità per la cura delle malattie prodotte dal maggiore inquinamento.
In conclusione, quello che sembrava un provvedimento di mera e fredda razionalità economica, si presenta ora come una politica che impatta seriamente sulla qualità della vita. Esso dimostra soprattutto l’assenza di una visione olistica del “bene pubblico”, capace di avviare un processo decisionale integrato che coinvolga i diversi comparti pubblici: Sanità, Viabilità, Logistica, Gestione dei tempi e della qualità della vita, sollecitando una riflessione a 360 gradi.
Come affermava Paul Watzlawick, infatti, “l’illusione più pericolosa è quella che esista soltanto un’unica realtà”.